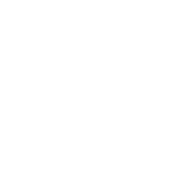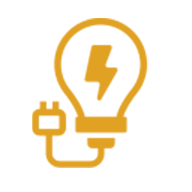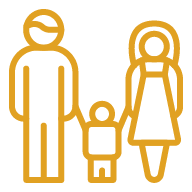di Laura Galas
Con una recentissima sentenza la Corte di cassazione è tornata ad affrontare il tema del licenziamento intimato al lavoratore sorpreso a svolgere attività lavorativa presso terzi durante l’assenza per malattia (Cass. civ. sez lav. – 26/04/2022 n. 13063)
Pur non sussistendo nel nostro ordinamento un divieto assoluto per il dipendente di prestare attività lavorativa, anche a favore di terzi, durante il periodo di assenza per malattia, tale condotta può pacificamente costituire giusto motivo di recesso da parte del datore di lavoro, ove esso integri una violazione dei doveri generali di correttezza e buona fede e degli specifici obblighi contrattuali di diligenza e fedeltà.
Ciò può avvenire, sostanzialmente, in due distinte ipotesi: quando l’attività lavorativa (prestata, o meno, a titolo oneroso) sia di per sé sufficiente a far presumere l’inesistenza della malattia, dimostrando quindi in re ipsa una sua fraudolenta simulazione; ovvero, quando l’attività stessa, valutata in relazione alla natura ed alle caratteristiche della patologia ed alle mansioni svolte nell’ambito del rapporto di lavoro, sia tale da pregiudicare o ritardare, anche potenzialmente, la guarigione e il rientro in servizio del lavoratore.
La giurisprudenza ha avuto modo di analizzare soprattutto i casi di idoneità dell’attività svolta dal lavoratore presso terzi a compromettere e ritardare la guarigione e pertanto di violazione degli obblighi di cura e di recupero delle energie psico-fisiche gravanti sul lavoratore.
In generale il lavoratore deve astenersi da comportamenti che possano ledere l’interesse del datore di lavoro alla corretta esecuzione della prestazione lavorativa e non può pertanto mettere a rischio con la propria condotta imprudente e volontaria il rientro al lavoro.
In tal senso il giudizio relativo all’idoneità di una condotta a compromettere la guarigione andrà effettuato in relazione alla natura della infermità e alla tipologia di mansioni svolte dal lavoratore, senza alcun riferimento all’effettivo slittamento del rientro al lavoro del dipendente.
In merito all’onere della prova un più risalente orientamento attribuiva al lavoratore l’onere di provare la compatibilità dell’attività svolta con le proprie condizioni di salute ed in particolare con la malattia impeditiva della prestazione lavorativa, in ragione della vicinanza dei fatti al lavoratore.
La Corte, oggi, sulla scia di un più recente orientamento (Cass. 1173/2018, Cass 13980/2020) ritiene invece che il datore di lavoro non possa limitarsi a fornire la sola prova che il lavoratore abbia svolto altra attività in costanza di malattia.
Il datore di lavoro deve, infatti, dimostrare tutte le circostanze oggettive e soggettive idonee a connotare l’illecito disciplinare, tra cui anche il fatto che la malattia fosse simulata o che la diversa attività posta in essere dal dipendente fosse potenzialmente idonea a ritardare o pregiudicare la guarigione e il conseguente rientro in servizio.
Questo onere discende dall’art. 5 L. 604/1966 che impone al datore di lavoro di provare la giusta causa o il giustificato motivo di recesso.
Per far ciò si dovrà valutare le modalità, i tempi e i luoghi della diversa attività svolta dal dipendente, attribuendo rilievo, anche ai fini dell’elemento soggettivo, al fatto che si tratti di attività ricreativa o ludica ovvero prestata a favore di terzi, le caratteristiche della patologia diagnosticata e infine se da tali elementi, eventualmente anche con l’ausilio di un perito, scaturisca la prova che la malattia fosse fittizia o che la condotta tenuta dal lavoratore fosse idonea a pregiudicare o ritardare il rientro al lavoro.
Secondo la Corte si tratta dunque di un onere probatorio stabilito per legge e che non può essere invertito dal Giudice in ragione di un generico criterio empirico di vicinanza della fonte di prova.